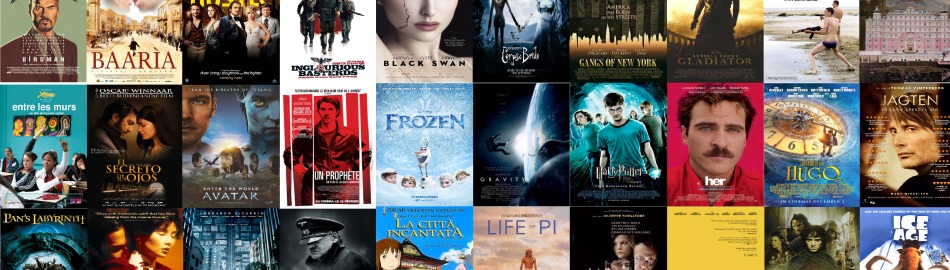
Come cambia il cinema del nuovo millennio
Se dovessimo stabilire l’inizio della nuova era cinematografica, non sceglieremmo il 2000 come la convenzione vorrebbe, ma l’11 settembre 2001. La tragica data degli attentati al World Trade Center è ormai unanimemente riconosciuta dalle indagini storiografiche come il terminus a quo dell’epoca attuale, con conseguenze dirette sulla nostra vita quotidiana, dalla politica alle manifestazioni sociali e culturali e, perché no, anche il cinema. L’11 settembre ha infatti costretto la settima arte, a partire da quella hollywoodiana, a rinegoziare il suo statuto, i suoi linguaggi e i suoi contenuti con le immagini del disastro che da quel giorno abbiamo visto e rivisto sui nostri televisori.

Il crollo delle Torri Gemelle, reiterato infinite volte dal circuito dell’informazione mediatica, ha segnato lo spartiacque tra il vecchio modo di raccontare il reale e quello odierno nell’età dei social network e dell’obiettivo onnipresente, fatto di riprese sempre più ravvicinate, invadenti, alla ricerca di corpi agonizzanti e martoriati: esecuzioni capitali che circolano via web, omicidi di afroamericani in diretta, cadaveri di profughi arenati sulle spiagge. Non si può pensare che la brutalità di questo spettacolo non abbia influito direttamente anche sul limite del visibile, o meglio di ciò che si può mostrare o non si può mostrare in un film di finzione, per soddisfare la curiosità e le aspettative di un pubblico sempre più assuefatto all’addomesticazione dello shock. È facile percepire gli effetti di ciò di cui parliamo nell’horror, sempre più compromesso con le dinamiche della guerra che ripropone nei suoi nuclei evenemenziali (cattura, prigionia, torture, stermini). Gore-porn, pseudo-snuff, torture-chic sono alcune delle etichette che indicano quanto il genere abbia portato all’estrema potenza la rappresentazione della violenza, con tutto il suo apparato di sangue, viscere e carni in bella mostra: Martyrs, Hostel, Saw la dicono lunga in merito, fino agli estremi e inguardabili The Human Centipede e A serbian film.

Anche la fantascienza ha assorbito il repertorio visivo contemporaneo, ma rielaborandolo in un immaginario catastrofico e inserendolo in un contesto alimentato dalle istanze sociali più che mai sentite, dagli allarmi ambientalisti (The Day After Tomorrow) alla contaminazione virologica (Doomsday, Contagion), dalle fobie escatologiche (2012) al terrorismo, seppur tinteggiato di fantasie intergalattiche come in Cloverfield. Restando in ambito fantascientifico, vive tutt’ora di rinnovato vigore il viaggio interplanetario, sia esso all’insegna dell’avventura nei classici panni della space opera, specialmente grazie ai sempiterni fasti di Star Wars, oppure in una veste esistenzialista e meditativa (Interstellar, Gravity). Gli esiti più stimolanti della SF del nuovo millennio sono offerti proprio da quella frangia filosofeggiante che proietta paranoie e fobie ancestrali in un inquietante scenario distopico (I figli degli uomini), e che si interroga sulla condizione dell’essere umano, scoprendone limiti e potenziali (Arrival), o ridefinendo il concetto stesso di umanità (The Lobster, District 9), spesso in relazione a un’alterità che assume connotati robotici (A.I. – Intelligenza artificiale, Ex Machina), a dispetto di chi pensava che il ragionamento intorno alle macchine non avesse più nulla da dire.
Per ragioni diverse, anche il macrogenere comico ha spinto con forza sul pedale dell’eccesso, sviluppando una tendenza già emersa negli anni Ottanta e portata a compimento dai Duemila, quando è esplosa con tutta la sua carica eversiva. È così che la battuta pornografica ha superato lo status di allusione per farsi quanto mai esplicita, i riferimenti ai fluidi corporei e alle flatulenze vengono cercati con ossessione, e la volgarità, anche linguistica, esibita con orgoglio. La deriva pecoreccia e demenziale sembra essere diventata la vera cifra della neo-commedia americana, tanto dei college movies per teenager (Maial College, sequel e spin-off di American Pie), quanto della grosse out indirizzata ad un target più vasto (Una notte da leoni, 2 single a nozze). Sta a noi comprendere, di volta in volta, se questa trivialità abbia un effetto liberatorio per lo spettatore in cerca di una valvola di sfogo, o serva soltanto a soddisfare una curiosità fine a se stessa; quel che è certo, è che la commedia assume un’importanza da non sottovalutare, specie nei periodi attraversati da gravi lutti e crisi collettive (recessione economica, calamità naturali, attentati terroristici di ieri e di oggi), quando il pubblico si riversa in sala per assistere agli spettacoli di evasione e ai generi popolari. Attualmente la commedia si impone come il contenitore più vasto, capace di produrre e di esplorare innumerevoli ramificazioni – si pensi alla commedia nera (Funeral Party), a quella sofisticata (I Tenenbaum), al film a episodi (Comic Movie), alla parodia (Scary Movie e affini) o al nostro cinepanettone – e al contempo rischia di affermarsi come il più tradizionalista, giacché sovente propone una comicità che finisce col perdere la propria energia sardonica nel momento in cui viene reiterata e istituzionalizzata.

In Italia, nel periodo in esame si è assistito al rafforzarsi di vere e proprie star del botteghino, assurte al rango di divi cinematografici e di padroni incontrastati del box office: Leonardo Pieraccioni (Il paradiso all’improvviso), Alessandro Siani (Il principe abusivo), Fabio De Luigi (La peggior settimana della mia vita), Checco Zalone (Quo vado?), Claudio Bisio (Benvenuti al Sud). Ma è un divismo di cui il cinema non può assumersi tutti i meriti, trattandosi di attori già collaudati sul palcoscenico o in televisione, spesso protagonisti di film la cui struttura è debitrice del cabaret e del varietà televisivo, con le sue gag di immediato consumo e i suoi deboli raccordi interni.
Non è invece riuscita a rinnovarsi con altrettanto successo la commedia sentimentale, privata sia di protagonisti significativi che di pellicole slegate dai cliché, dalle caratterizzazioni e dai codici culturali del passato. Com’è ben noto, in realtà, i limiti cronologici, compreso quello che abbiamo scelto come punto d’avvio, funzionano come delle pure e semplici convenzioni per chi voglia osservare i flussi e i cambiamenti che occorrono nel tempo, ma quasi mai assumono la consistenza d’un muro invalicabile. Somigliano, piuttosto, a delle staccionate, e accade che, nel salto, qualcosa resti azzoppato. È il caso del filone romantico della commedia, appunto, ma anche del musical, la cui capacità di imprimersi nell’immaginario collettivo appare decisamente ridimensionata rispetto all’epoca d’oro, persino per talune produzioni pluripremiate (Lés Miserables) e con grande sfoggio di scenografie sontuose e cast stellari (Nine), mentre le due grandi eccezioni di Moulin Rouge! e Chicago, collocate come sono a ridosso del secolo scorso, lasciano un’eredità che finora non è stata raccolta. Quanto al western, invece, la china su cui s’è incamminato non è storia recente, nonostante la breve parentesi delle ibridazioni tarantiniane (Django Unchained, The Hateful Eight).

In caduta libera è anche il cinema d’azione nudo e crudo, così come abbiamo imparato a conoscerlo negli anni Ottanta e Novanta, che, se considerato al di là delle contaminazioni con la science fiction, non ha abbastanza forza nei muscoli per far presa sulle nuove generazioni. Il fatto che non si siano trovate delle soddisfacenti alternative a Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis, Harrison Ford, Mel Gibson e Jean-Claude Van Damme spiega anche perché gli studios abbiano deciso di riportare in vita le saghe di Die Hard, Terminator, Rocky, Rambo e Indiana Jones, nonché di realizzare quella summa dell’universo action vecchio stile che è il franchise de I mercenari.
Sul versante opposto, il film fantastico, sia nella rivisitazione dell’epica che nell’habitus propriamente fantasy, ha dimostrato una capacità di imporsi all’attenzione del grande pubblico appropriandosi di storie originariamente pensate per altre forme di fruizione (libri, fumetti, videogiochi), ridando gloria e lustro ai temi del viaggio, della magia e della battaglia tra bene e male, e facendo a meno una volta per tutte del divismo. Tra i maggiori incassi del periodo vanno annoverati titoli come Pirati dei Caraibi, Hunger Games, Twilight, artefici non soltanto della celebrità di attori altrimenti sconosciuti (cosa sarebbe Daniel Radcliffe senza Harry Potter?), ma soprattutto di una vera e propria rivoluzione nell’immaginario cinematografico e nelle logiche di produzione e distribuzione, che prevedono ormai una massiccia campagna pubblicitaria e di merchandising, con l’esplosione di fenomeni di culto che fatturano guadagni inestimabili. Non è da sottovalutare, inoltre, che alcuni di essi riescano ad ottenere il clamoroso consenso della critica, e qui basterà vedere alla voce Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re. Persino l’industria italiana, che non ha una consolidata tradizione in materia, ha dato vita in questi anni a pellicole fantastiche colte e semifumettistiche quali Il racconto dei racconti, Il ragazzo invisibile e Lo chiamavano Jeeg Robot, che hanno fatto parlare di una (ri)nascita di un settore inusitato.

Sono proprio i film che rientrano sotto la generica definizione del fantastico ad aver contribuito alla resurrezione in magna pompa di due figure tipiche del cinema horror del Novecento: lo zombie e il vampiro. Coadiuvato e incoraggiato dalla serialità televisiva, il 21° secolo ha alimentato la mitografia dei due leggendari villain spogliandoli – quel che è più significativo – delle sovrastrutture che ne facevano portatori di valori sociali e dei canoni estetici che li rendevano ributtanti. Il mutamento di segno che ne consegue implica anche un sovvertimento dei codici e degli atteggiamenti dentro e fuori la pellicola, intendendo con questo l’esercizio di una seduzione sullo spettatore da parte del mostro ora privato proprio della sua mostruosità. Si può facilmente notare come gli zombie siano diventati il bersaglio di una parodia geniale (L’alba dei morti dementi), oggetto di una banalizzazione in salsa teen (Maial Zombies – Anche i morti lo fanno), o di una migrazione verso il sentimentale (Warm Bodies). Ancora più fortunati sono i vampiri, evolutisi in creature bellocce, fascinosamente al confine tra malvagità (Fright Night – Il vampiro della porta accanto) e bonarietà (Dark Shadows), nel mirino delle logiche da blockbuster (Twilight) o della ridicolizzazione (Mordimi).

Continuando a ragionare in termini di linguaggi e di strutture narrative, va registrato pure il considerevole aumento di film in cui la linea temporale è sempre più aggredita, manipolata, distorta. Influenzato dalle tecnologie digitali e dal sopravvento di Internet, il racconto cinematografico sovrappone passato, presente e futuro, scuote la tradizionale visione cronologica degli eventi e coinvolge attivamente lo spettatore nell’interpretazione. Si tratta di un’esposizione che trova ben noti precedenti nel cinema classico e negli anni Novanta, ma che diviene sistematica e incredibilmente caotica a cavallo tra i due secoli. Appartengono alla categoria quei film in cui il tempo precipita in una lunga presentificazione (21 grammi), si contrae, si biforca e si riscrive (Mr. Nobody), in cui il viaggio a ritroso si manifesta in modi bizzarri (Primer), o il finale obbliga a una rilettura degli eventi cui abbiamo assistito fino a quel momento (Vanilla Sky, Donnie Darko). Non di rado la focalizzazione segue un personaggio in preda a problemi d’identità (Mulholland Drive), affetto da amnesia (Memento) o da disturbi psichiatrici (Il cigno nero), e nemmeno l’animazione ne è esente (Valzer con Bashir).
L’ultimo accenno ci permette di passare rapidamente a un’altra protagonista di questa lunga stagione cinematografica. Oggigiorno nessuno più si stupisce nell’apprendere che i lungometraggi animati si accaparrano, ogni anno, una grossa fetta del mercato: merito del riuscito connubio con le tecniche digitali d’avanguardia, ma soprattutto di una politica culturale che concilia classico e moderno, sfornando sceneggiature di notevole qualità. A farla da padrona è la Pixar, che ha messo in campo una sfilza di soggetti sempre nuovi, ricorrendo assai poco alla serialità, e offrendo una mescolanza di

ingenuità e nostalgia buona per i bambini quanto per i più grandi. Negli anni, la casa di produzione ha saputo reinventare con originalità i temi tipici della fiaba (il viaggio, l’avventura, il confronto con la diversità), coniugandoli con quelli quotidiani della crescita e dei rapporti familiari (Inside Out), e proponendo la più vasta gamma di personaggi (animali ed esseri umani, ma anche robot, creature fantastiche e oggetti inanimati). E non solo, in quanto è riuscita a districarsi sapientemente tra temi e stili differenti, dalla fantascienza (WALL•E) a inaspettate antropomorfizzazioni (Ratatouille) fino alle lunghe sequenze in cui la comunicazione verbale è del tutto assente (Up).
Una simile sperimentazione, ma molto meno politically correct, si ritrova forse soltanto in Shrek, l’orco verde della Dreamworks, che alterna grossi successi (Madagascar, Kung Fu Panda) a film privi dello stesso carisma. Tiene bene anche la Disney, decisamente improntata al conservatorismo e al rimodellamento di un serbatoio già consolidato, anche se gli esiti più recenti lascerebbero presupporre un cambio di rotta (Zootropolis, Big Hero 6) e un ritorno ai fasti d’un tempo (Frozen – Il regno di ghiaccio). Ma per la critica specializzata il miglior film degli anni Duemila è La città incantata, il capolavoro del giapponese Hayao Miyazaki, il principale fautore del trionfo dell’animazione asiatica in Occidente. Vale la pena di ricordare, a questo punto, anche la prosperità di un’animazione fiorita al di fuori degli studios americani e marcatamente rivolta a un pubblico adulto, vuoi per la scelta dei temi trattati (Persepolis), vuoi per le inconsuete modalità di narrazione adottate (Appuntamento a Belleville), non di rado frutto di un’autorialità che si manifesta anche in questo settore, sia essa occasionale (Charlie Kaufman) o continuativa (Satoshi Kon).

Resta da passare rapidamente in rassegna alcune tra le principali cinematografie nazionali. In Europa, gode ancora di ottima salute il magistero della Francia, la cui immagine è spesso associata alle commedie raffinate e originali di cui è produttrice (Quasi amici – Intouchables, Il favoloso mondo di Amélie) esportate in tutto il mondo. Non va dimenticato, però, che il Paese è anche la patria di alcune tra le più controverse e discusse pellicole connesse con l’esplorazione della sessualità (La pianista, Intimacy, La vita di Adele), o di talune, scomode, questioni sociali d’attualità (La classe – Entre les murs, Dheepan – Una nuova vita), a volte finanche profondamente drammatiche (Amour).
Fonte inesauribile di storie è la Seconda guerra mondiale, ricordata da vicino o per allusione, quasi sempre in un’ottica poco spettacolare, lontana dalla messa in scena del conflitto come accade per gli Stati Uniti. Curiosamente, è stata la Germania a distinguersi in questo tipo di produzioni, collettive (Il pianista) o autonome (La Rosa Bianca – Sophie Scholl), mettendo a punto addirittura un filone a sé stante, quello sulla figura del dittatore del Reich (La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler), persino in chiave satirica (Lui è tornato).
Dominano incontrastate, nel nord del continente, le atmosfere tenebrose, pesanti, sconvolgenti, perfettamente calate nel dramma familiare, nel film storico o nel thriller introspettivo. I casi eccellenti sono costituiti dalla Svezia e dalla Danimarca, con il proseguimento di decennali tendenze nazionali (Lasciami entrare), il riconoscimento ufficiale nelle manifestazioni che contano (Dancer in the Dark) e svariate imitazioni nei remake americani (Uomini che odiane le donne). Particolarmente vitale continua a essere il cinema in lingua spagnola, con notevoli propensioni al sovrannaturale orrorifico (Rec, La spina del diavolo) e alla rappresentazione dei miti nazionali (Neruda, I diari della motocicletta), per quanto l’exploit di queste industrie nazionali sia spesso dovuto all’opera di pochi autori (Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar), sovente trapiantati con successo nell’ambiente hollywoodiano (Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu). Non molto dissimile, da questo punto di vista, è la situazione di certe cinematografie minoritarie, la cui fama è legata esclusivamente all’opera di singole personalità di spicco, come Yorgos Lanthimos per la Grecia e Cristian Mungiu per la Romania. Non si smetterà mai, pertanto, di insistere sull’importanza che i festival cinematografici (Cannes, Roma, Berlino, Sundance, Toronto, Venezia) hanno per le opere che altrimenti rischierebbero di restare sommerse dal mare della concorrenza.

E in Italia, cos’è cambiato? Vale per il nostro cinema quanto detto a proposito della commedia, o in senso più ampio il film d’intrattenimento pensato per il grande pubblico, che ha capitalizzato il processo produttivo, distributivo e infine anche il consumo dell’utenza. Oggi come oggi si va al cinema per vedere un film leggero. E chi non è un frequentatore abituale della sala, di solito vi si reca solo per assistere alla commedia dell’anno, qual è stato il caso di Zalone. Anche l’esplorazione dei generi meno praticati, cui pure accennavamo prima, è in realtà finora un timido tentativo di fronte ad un’offerta che sembra essersi omogeneizzata, appiattita su un solo modello. Il quale, comunque, è già un modello che prevede molteplici diramazioni. Ad uno sguardo più attento, non c’è soltanto il film stagionale (estivo o natalizio) sui soliti vacanzieri, il buddy movie o il comico-demenziale, ma c’è spazio anche per le innovazioni intelligenti e le osservazioni caustiche su vizi e virtù degli italiani. Andrebbero annoverati almeno la commedia al femminile (Amiche da morire), agrodolce (Tutta la vita davanti), il film sugli scontri generazionali (Genitori e figli) o sui problemi di coppia (Manuale d’amore, Ex), fino alle soluzioni più originali e apprezzate (Incantesimo napoletano, Perfetti sconosciuti). Il cinema italiano è tutt’altro che morto, e a dirla tutta non ci pare nemmeno in crisi. Il problema, semmai, sta nella distribuzione e nell’esercizio, che mettono anche il cinefilo appassionato nella condizione di dover inseguire un film e alla fine rinunciarvi.
I Duemila ci hanno indotto, ad esempio, a navigare tra canali vecchi e nuovi, ben rappresentati i primi dal filone poliziesco (ACAB – All Cops Are Bastards) e criminale (Suburra, Romanzo criminale), a volte inviluppati nella ricostruzione di eventi recenti (Diaz – Don’t Clean Up This Blood), e i secondi dalla propaggine adolescenziale (Notte prima degli esami e la deriva mocciana). Ma sono stati, questi, anche gli anni della definitiva consacrazione di registi che hanno fatto il loro esordio negli anni Novanta (Emanuele Crialese, Ferzan Özpetek) o il decennio seguente (Fausto Brizzi, Giorgio Diritti), e della trasferta hollywoodiana dei vari Gabriele Muccino (La ricerca della felicità), Giuseppe Tornatore (La migliore offerta) e Paolo Sorrentino (La grande bellezza), l’ultimo insignito, come ormai tutti sanno, del più grande riconoscimento internazionale che si possa vantare.
Andrea Vitale

