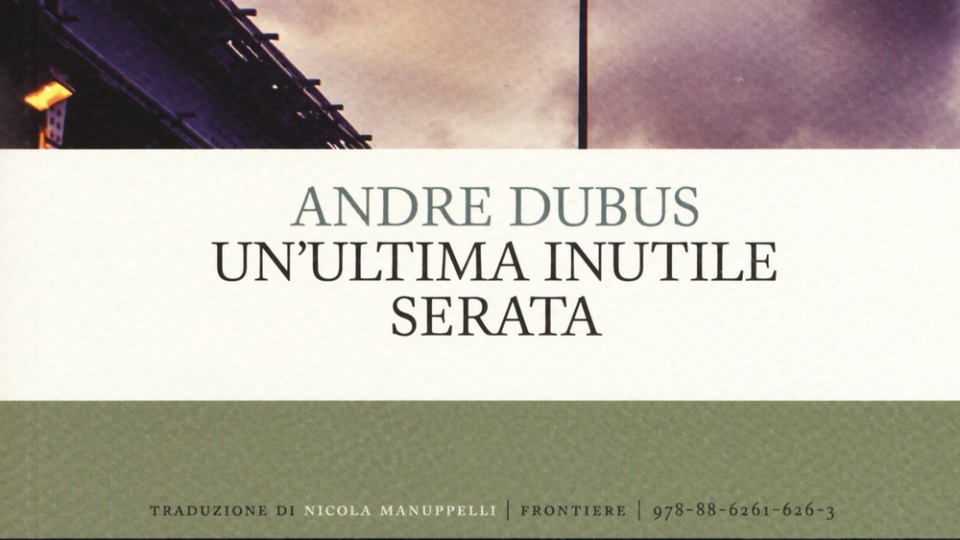
Un’ultima inutile serata. Dubus e i grigi punti di svolta
Willie e io ridevamo di un altro tipo di morte: non una morte per colpa di un’esplosione, istantanea, ma una morte centellinata, minuto per minuto, giorno per giorno, per secoli, la morte della sicurezza, della giustizia e della speranza per un’intera popolazione di americani, e ridevamo anche per una morte più sottile – perché la sofferenza è più sottile, addirittura impercettibile – che è quella dei bianchi.
– Le morti in mare [Andre Dubus, Un’ultima inutile serata, Mattioli1885, 2017, p. 41]
È del 1986 la raccolta di racconti di Dubus, uscita qualche mese fa per Mattioli1885. Un’ultima inutile serata è un libro che si pone in un periodo particolarmente felice per l’autore – un vero picco di felicità e soddisfazione artistica – e al contempo nel peggior periodo della sua vita, quando in seguito a un incidente stradale perderà l’uso di una gamba e sarà costretto sulla sedia a rotelle per il resto della sua vita.
Paradossalmente, un momento di passaggio fondamentale nell’esistenza dell’autore americano. Paradossalmente, perché in questa raccolta ci troviamo davanti a sei racconti (quattro lunghi e due brevi, come specifica il sottotitolo nell’edizione originale) in cui viene mostrato un punto di svolta, un momento esistenziale in cui qualcosa cambia, in cui si cammina nell’irrequietezza che precede il cambiamento, o in cui quel cambiamento l’abbiamo appena vissuto (appena, o un lasso di tempo enorme che ci sembra tuttavia passato in un istante) e siamo pronti a raccoglierne i frutti.
Questo libro ci spinge a pensare che la sera e la notte siano protagonisti – o almeno sfondi onnipresenti – ma in realtà l’inutile serata è più una condizione mentale, una prospettiva dei personaggi. E Dubus ha la capacità di porsi in una condizione sempre laterale, parziale, e raccontare storie di cambiamento e sofferenza attraverso uno sguardo partecipe e distante allo stesso tempo. Come se i pensieri del narratore fossero pronti a registrare gli eventi che accadono sotto i suoi occhi, ma al contempo pronti a interpretare quegli stessi accadimenti in funzione del proprio singolare passato o presente. Uno sguardo al come i mondi personali si intersechino attraverso le esperienze.
Lo stile di Dubus è preciso, dal punto di vista linguistico si perde di rado in parole di troppo. È un artigiano. Al contrario, si lascia andare in digressioni nell’aspetto contenutistico, talvolta per mostrare scene di contorno che non interessano più di tanto per contestualizzare o per dare forme specifiche ai personaggi, ma per suggerire un particolare tono, una definita atmosfera.
In quest’ottica, leggere il primo dei racconti – Le morti in mare – è affrontare la lunga storia del razzismo in America attraverso gli occhi di due marines. Una storia ambientata agli inizi degli anni ’60, in cui il protagonista bianco è reduce di una cultura razzista di cui si vergogna, e ha l’occasione di riscattare l’intera sua etnia – se così si vuol definire – tramite il suo nuovo compagno di stanza, un marinaio nero, Willie. E – a posizioni invertite – è Willie stesso a permettere questa purificazione.
“Che ne dici se ci stringiamo la mano?” ho detto. “O vogliamo rimanere qui a interrogarci su quanto possa essere disdicevole?”
Le morti in mare [cit., p.21]

E in una raccolta di tutti racconti carichi di forza espressiva, è anche esemplare il racconto di mezzo – quello dal titolo fenomenale: La terra dove sono morti i miei padri – in cui si inscena un omicidio e l’avvocato di un accusato innocente (e stupido) dovrà venire a capo dei fatti. Ma al di là della trama gialla, al di là dell’assassino e dell’innocente, ecco che si dipana una storia di persone, dove ci si ripulisce da colpe e innocenze e si affronta la vita per quel che è, una grossa, indistinta macchia di grigio, una nebbia entro cui cerchiamo, nostro malgrado, di tirarcene fuori con meno acciacchi.
“Nella mia vecchia Volvo, una volta aperto il finestrino per fare entrare un po’ d’aria fresca, e smaltita la stanchezza che provavo quando mi capitava di fare un’azione buona che non mi andava di fare, improvvisamente mi sentii felice che mi avesse chiamato. Una sensazione che mi sorprese e poi mi turbò, perché a trentatré anni non dovrei più sorprendermi”.
La terra dove sono morti i miei padri [cit., p.116]
Maurizio Vicedomini

