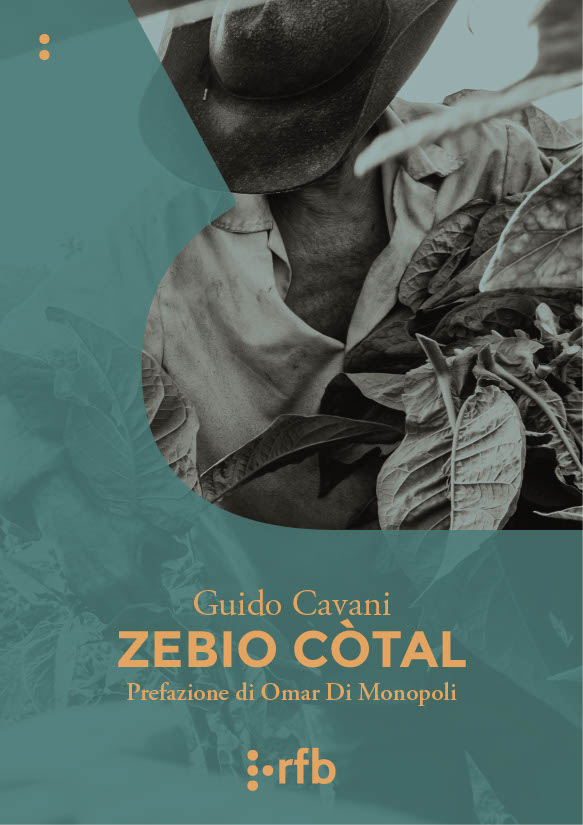
Di uomini e terra. Zebio Còtal di Guido Cavani
Quest’anno ritorna in libreria un grande dimenticato della nostra letteratura del Novecento. Guido Cavani è stato poeta e narratore, e ha sfornato – stando alle parole di Pasolini – un “piccolo capolavoro”. Zebio Còtal, un libro prima autoprodotto, poi ripubblicato da Feltrinelli all’inizio deli anni ’60 e oggi riportato in libreria da Readerforblind, una casa editrice specializzata – per ora – nel recupero di grandi testi dimenticati.
Zebio pensò che la vita degli uomini era simile alla vita del bosco: parassitaria, crudele; affidata alla forza e agli istinti più che al buon diritto di ciascuno e all’amore di tutti; fatta di apparenze più che di verità; falsa tanto nel bene quanto nel male.
Zebio Còtal, G. Cavani, Readerforblind, p.137.
Cavani e il suo tracciato
Pubblicato sul finire degli anni ’50, Zebio Còtal è un romanzo che affronta la vita dell’intera famiglia Còtal – marito, moglie e sei figli -, poveri contadini nel modenese. Gente che vive una vita di stenti. L’intento di parlare di un gruppo di personaggi, più che di uno solo, è evidente sin dall’inizio. Infatti, ci si aspetterebbe che un romanzo intitolato come uno dei personaggi lo abbia per protagonista assoluto. E invece il primo capitolo si apre su Zuello Còtal, il maggiore fra i figli maschi, nella sua “avventura” che lo porterà a essere messo a servizio da un parente, così che casa Còtal abbia una bocca in meno da sfamare.
Fatta eccezione per i due figli più piccoli, il cui peso e presenza nella narrazione sono minimi, tutti gli altri personaggi hanno uno sviluppo preciso e individuale, e l’intreccio di questi conduce alla vera complessità del romanzo nel descrivere non la povertà o la grettezza di un singolo uomo, ma la condizione di malessere condivisa e le possibili sorti a cui questa conduce.
Cavani si pone in prosecuzione di un fil rouge che va almeno da Verga e passa per il Silone di Fontamara. Con la differenza che i “cafoni” di Cavani non s’immergono nella Storia (quella con la esse maiuscola): la dimensione del narrato resta sempre locale, intimo, con l’occhio ben puntato sugli individui.
Come la terra. Zebio
Zebio è il padre di famiglia. Ci pare la descrizione più calzante quando lo incontriamo all’inizio del romanzo. Ma le pennellate di Cavani ce lo dipingono presto come un fannullone che preferisce far lavorare moglie e figlia maggiore, come un uomo violento, brutale, beone. Un uomo incapace di provare empatia. Anche davanti alla sofferenza, al dolore, alla morte, Zebio resta tutto sommato impassibile: continua a sfogarsi nel vino, incarcerato nella propria dimensione di uomo grezzo.
L’unico vero legame sembra con il suo piccolo pezzo di terra. La terra che suo padre e suo nonno hanno lavorato e che ora è suo – dice – soltanto suo. Una terra che fa più gramigna che frumento, arida più di ogni altra in zona. Non è errato, a parer mio, cercare in questo una descrizione che Cavani ci fa dello stesso protagonista, poiché la sorte che attende Zebio e il campo è tutto sommato simile.

La sorte di un pover’uomo?
Cavani è particolarmente bravo – soprattutto nella seconda metà del libro – a spingere il lettore a empatizzare con Zebio Còtal, un uomo a cui vanno storte molte cose e che non riesce a far quadrare la sua esistenza. Ma al contempo è evidente la contraddizione di uomo che non ha la forza (e forse nemmeno la volontà) di intraprendere un vero cambiamento. Noi lettori ci troviamo allora combattuti: l’uomo oppresso dal destino, un “povero figlio di Dio” sfortunato, e al contempo il violento che non conosce altra via se non la rabbia, un uomo che piange miseria più di quanto non lotti per rialzarsi. Un uomo che – in fondo – cerca sempre la strada facile.
È forse in questa contraddizione che si sviluppa il romanzo di Cavani. Una narrazione forte, capace di delineare personaggi vividi e umani. Un intreccio dove la voglia di riscatto abbraccia la rassegnazione di chi non vede vie d’uscita. Generazioni diverse, indoli diverse. Un pezzo di storia della letteratura italiana che vale la pena riscoprire.
Zebio si mise a girare fra le mani il cappello. Ora era calmo, insensibile a tutto; il suo cuore aveva ripreso a battere regolarmente, come se nulla di nuovo dovesse avvenire, come se il tempo si fosse fermato. Solo quando i suoi occhi, che frugavano in tutti gli angoli della stanza, senza curiosità, si posarono sul crocifisso che pendeva dalla parete di fronte, qualcosa di dimenticato si risvegliò in lui illuminandogli l’anima. Sentì però di non essere degno di guardare la faccia del Figliuolo dell’Uomo e nello stesso tempo capì che se quelle povere braccia avessero potuto schiodarsi lo avrebbero abbracciato.
Id, p.183.
Maurizio Vicedomini

