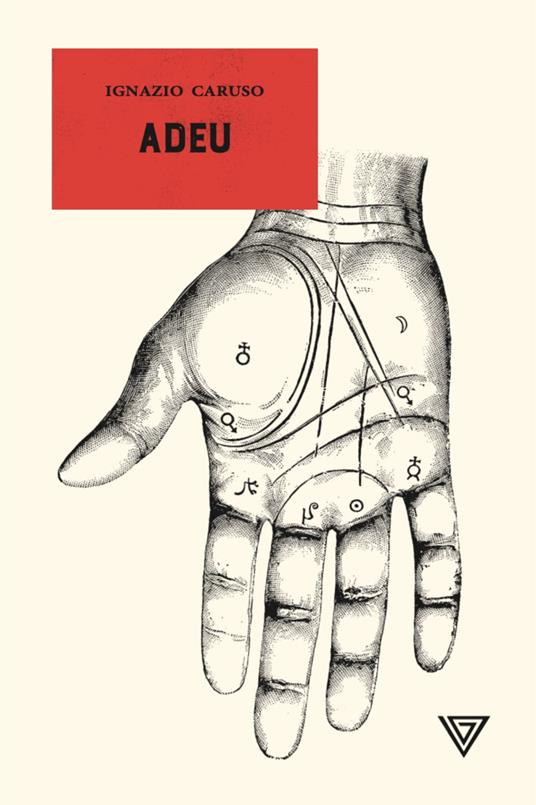
Uccidere per essere liberi di crescere. L’esordio di Ignazio Caruso.
In un’epoca di crescenti inquietudini esistenziali intorno al destino dell’uomo, posto sempre più spesso di fronte a eventi percepiti (e narrati) come più grandi di lui – la pandemia, la guerra, il disastro ambientale – il romanzo d’esordio di Ignazio Caruso, Adeu (Giulio Perrone Editore), crea un senso di straniamento che al contempo ci distacca e ci restituisce a tali inquietudini, spostando l’attenzione dal decadimento esterno alla società a quello interno, nucleare, del rapporto tra genitori e figli, tra vecchi e giovani. Questo slittamento di prospettiva ci cattura immediatamente, ci incuriosisce, ci trascina in una storia in cui nessuno può sottrarsi all’azione individuale con la scusa che il problema da affrontare è troppo grande, sebbene, nel caso di Adeu, si tratti di un’azione feroce: giunti alla maturità, i figli devono uccidere i propri genitori, ormai inabili al lavoro e dunque socialmente inservibili. Una sorta di distopia capitalista che porta all’estrema conseguenza l’economia delle risorse (qualcuno oggi la chiamerebbe “rottamazione”), in base al principio per cui, se tutto funziona e tutti hanno un lavoro, è “anche perché chi doveva farsi da parte si faceva da parte (insomma, veniva messo da parte).”
In un’isola presto identificabile con la Sardegna in cui l’autore è cresciuto (Cadossene, nella storia), e specialmente con l’Alghero linguisticamente ibrida e impastata di tradizioni antiche (Algàr), troviamo infatti, come protagonisti, un padre e un figlio, Nevio ed Eloi Barra. Ex fabbro e lavoratore infaticabile, dopo la morte della moglie Nevio si è dedicato esclusivamente alla cura del figlio, guidandolo con pazienza attraverso la giovinezza fino all’età adulta, perdonandogli la sbadataggine e affinando persino la ricetta della “pastalsugo” per renderla quanto più simile a quella della moglie. Eloi, da poco assunto “all’Ofici Postal”, è un trentenne un po’ distratto che spesso tira tardi e si concede un bicchiere di troppo, ma che tutto sommato sembra condividere col padre l’animo gentile e un modo di comunicare intermittente, in cui parole e silenzi sono ugualmente eloquenti.
Quando la lettera del “Ministeri Demogràfic” arriva tra le mani di Eloi, informandolo che la procedura di Adeu è stata avviata, Eloi vorrebbe prendere tempo, ma a Nevio basta incrociare il suo sguardo per capire che la sentenza è stata emessa. Senza chiedere niente mette via le sue cose, fa le valige e si prepara al viaggio verso il Monte, dove il figlio dovrà condurlo e infine ucciderlo a randellate (l’utensile prescelto non a caso si chiama Randel).

Anche in questo caso, se Eloi rimugina e rinvia, Nevio affronta coraggiosamente il presente e fa tutto ciò che è in suo potere per sobbarcarsi il carico emotivo del figlio, parlandogli dell’Adeu come di un fatto naturale. Naturale è, d’altronde, tutto ciò che è voluto dagli dèi, e in questo caso non poteva certo mancare un mito fondativo. A Cadossene si narra infatti che il dio Cronos, figlio di Uràn, uccidesse i suoi figli per paura che i figli uccidessero lui, finché uno di loro, Deu, riuscì a sottrarsi e uccidere il padre, ripristinando l’ordine e inaugurando il rito dell’Adeu.
I concetti su cui è costruito il romanzo – il vecchio che deve lasciare il posto a un nuovo “eterno”, nonché il distacco dai sentimenti più elementari – non sono inediti in letteratura. Gli esempi spaziano dalla mitologia, da cui Adeu, appunto, attinge a piene mani, rivisitando il mito di Zeus che uccide il padre Crono, alle tradizioni popolari (anch’esse presenti), fino alla tipica letteratura distopica, in cui un “superstato”, oltre alla vita comunitaria, regola i rapporti più intimi. Vengono subito in mente classici come Il mondo nuovo di Huxley, in cui si sacrifica qualunque forma di umanità in nome di “Comunità, Identità, Stabilità”; il best seller più noto di questo genere, 1984, ma anche esperimenti cinematografici come Equilibrium (Kurt Wimmer, 2002), in cui i cittadini sono tenuti ad assumere un siero che inibisce le emozioni al fine di garantire la pace sociale. Il fil rouge che unisce questi racconti è il desiderio di cancellare sistematicamente la memoria attraverso procedure e riti codificati, poiché in essa si radica, in ultima analisi, l’attaccamento; lì nasce l’idea dell’amore, opposta a quell’iper-individualismo che è invece necessario a svuotare l’uomo dei suoi sentimenti per renderlo una macchina che produce.
Ed ecco che a tentare di fugare i dubbi di Eloi circa il rito da compiere sono anche i personaggi secondari: l’amico Pau,che dopo l’uccisione del padre “era rinato”, i gelidi funzionari della República, ma anche la fidanzata Tea, graziosa creatura di buona famiglia che pare essergli affezionatissima, ma che sulla faccenda dell’uccisione del padre rivela un cinismo al limite dell’inclemenza. È lei a ricordare a Eloi che “Essere figli è un diritto, essere liberi è un dovere”, distillando in questa formula ministeriale il concetto che sottende l’intero romanzo: la libertà è un atto divisivo, di separazione dell’altro e affermazione di sé. Per essere liberi bisogna dire addio, Adeu.
Per farsi coraggio, d’altronde, Eloi deve invaghirsi continuamente della narrazione altrui, deve convincersi del sentimento degli altri, poiché, pur sforzandosi di razionalizzare, non riesce a fidarsi del suo. “Il suo amico Pau”, lo fa riflettere Tea, “se n’era forse pentito? E tutti i giovani, chi più chi meno, che ogni giorno affollavano i pendii del Monte trascinando i loro padri e le loro madri, se avesse parlato con chiunque di loro, anche col più incerto, dopo che aveva fatto quel che doveva fare, l’avrebbe mai trovato in preda anche solo a un pizzico di rimorso? Ma no! Una volta liberi, tutti avevano ripreso le loro vite. Anzi, tutti le avevano «migliorate». Libertat!”
Tuttavia, nel crescere di questa tensione narrativa tutta orientata a un momento preciso – l’ascesa al Monte – nessuna di queste argomentazioni sembra penetrare davvero fino al cuore di Eloi (nessuna, dunque, convince pienamente il lettore, che si immedesima a fasi alterne con Eloi ma che concede alla storia solo una parziale sospensione dell’incredulità, monitorando sempre l’allegoria, la critica sociale). A restituire questa titubanza è anche l’organizzazione non lineare del romanzo, i cui brevi capitoli alternano passato e presente, creando una giustapposizione di scene che il più delle volte raggiungono l’apice negli scambi di tenerezza (più o meno goffa) tra padre e figlio; dunque nei momenti in cui la necessità della separazione è messa quanto mai in discussione. Spetta al lettore scoprire se e come questa incertezza verrà risolta.
Insegnante di italiano nelle scuole superiori e appassionato di letteratura, nel suo primo romanzo Ignazio Caruso si destreggia in un genere complesso per trattare in modo originale un tema che sente vicino, quello dei trentenni che non trovano un posto nel mondo perché spesso quel posto è già occupato da chi, nonostante l’età, non si decide a fare “largo ai giovani”. Per farlo si prende tempo e spazio (quasi trecento pagine), lavora sui dettagli e gioca con la lingua (il testo è costellato di citazioni in un idioma che mischia sardo, spagnolo e francese), senza mai perdere la presa sul lettore. La scrittura è fresca, i dialoghi funzionano, la geografia del romanzo emerge con chiarezza e noi concludiamo la lettura pieni di impressioni e domande, quindi certi di aver letto un buon libro.
“Quali oscuri demoni si affollino nelle parti molli di un uomo, banchettando al tavolo del suo petto tra urla e schiamazzi, cibandosi degli ultimi grani di tempo rimastigli […] è una domanda a cui solo gli dèi possono dare risposta. A chiunque si interroghi su questa materia tanto fosca, però, non sfuggirà certo la possibilità, possibilità che lambisce la certezza, che questi determinati pensieri si rivolgano solo ed esclusivamente al passato. Perché è così che gli dèi hanno ripartito la conoscenza del tempo: per loro hanno tenuto le cose che avverranno; per i giovani ciò che è necessario, ovvero le cose che stanno avvenendo; ai vecchi, invece, non hanno lasciato che la polvere delle cose”.
Elena Panzera

