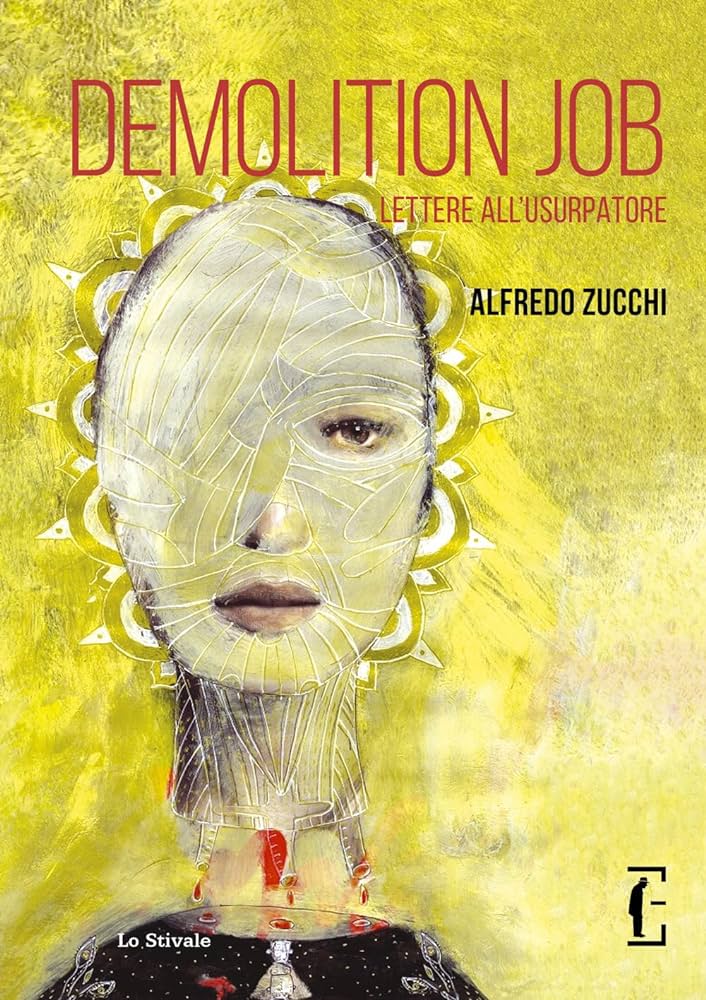
Di chi è il senso? Su Demolition Job di Alfredo Zucchi
Con Demolition Job (Edicola Ediciones, 2023), Alfredo Zucchi costruisce un’impalcatura di cinque racconti destinata ad auto-sabotarsi, senza cedere, però, al compiacimento meta-testuale più facile. La violenza, le implicazioni politiche e l’ambiguità dei ruoli attanziali gli impediscono infatti di risolvere completamente la narrazione nella dimensione autotelica e di sollecitare, nel lettore, un rapporto agonistico, complesso, coi testi.
Il dispositivo del laboratorio
Il gusto meta- e inter-testuale, in realtà, riguardava già il precedente La memoria dell’uguale (Polidoro Editore, 2020)[1]. Rispetto a quello, però, Demolition Job sembra abbandonare le componenti rituali e sacrificali (di sapore sudamericano) e spostare l’impianto immaginativo più sul contesto scientifico, in ambienti più asettici e rapporti tra personaggi di una crudezza magari meno spettacolare (sono molte le morti violente nella Memoria), ma proprio per questo più inquietanti.

In questo senso (quindi sia in termini di immaginario sia in termini, potremmo dire, emotivi) l’immagine del laboratorio sembra giocare un ruolo decisivo. Al laboratorio è del resto dedicato il racconto centrale e più corposo, Resoconto sperimentale. Qui, con una lingua da diario scientifico, si racconta in prima persona la storia di un esperimento in cui i ruoli di cavia e sperimentatore, vittima, carnefice e osservatore, si scambiano continuamente assieme al fluttuare ininterrotto delle coordinate epistemiche e performative dei test, cui la voce che dice io può obbedire solo tramite un gesto di fiducia incondizionata (benché costantemente meditata): «Dare senso era il nostro dono all’esperimento, anche quando ci sembrava di non capire niente – proprio allora si manifestava la nostra fede nel processo: quando tutto mancava, quando l’orizzonte sembrava oscurarsi e immobilizzarsi, noi continuavamo a raccogliere e catalogare dati nella speranza che un’idea, un modello nuovo, una forma, si sarebbero presentati ai nostri occhi per permetterci di abbracciare quell’insieme caotico di cose senza direzione».
Ecco dunque il valore narrativo e filosofico del laboratorio: uno spazio in cui gli eventi sono suscitati al fine di studiarli e di teorizzare delle leggi, ma, contemporaneamente, uno spazio in cui il progetto degli sperimentatori incide sulla condotta dell’evento. Detto altrimenti: uno spazio in cui simulazione e realtà, scoperta e violenza si sovrappongono e fraintendono reciprocamente. La centralità del laboratorio non è tale, dunque, solo per il Resoconto, ma si estende all’intero dispositivo del libro, e riguarda la teoria della scrittura cui si rifà Zucchi. È d’obbligo, infatti, confrontare quanto detto finora con questo passo tratto dal saggio Una possibilità del linguaggio (Mucchi Editore, 2021)[2], dello stesso autore: «il laboratorio centrale [è] una dimensione in cui non solo il linguaggio implica se stesso, ma ogni elemento – spaziale, temporale – è legato all’altro in una relazione di autoimplicazione [e] persino lo spazio e il tempo sono il linguaggio». Per molti versi, il laboratorio di Resoconto sperimentale non è che l’attuazione pratica, narrativa, di un’immagine già usata da Zucchi per descrivere il «luogo ambiguo in cui si tenta di assegnare i nomi alle cose per la prima volta» cui punta la scrittura.
Introflessione e ritorsione
Proprio a partire dal fatto che il dispositivo del laboratorio porta all’interno di una pratica relazionale (oltre che scientifica) la fallibilità, convenzionalità e messa in crisi del linguaggio, la dimensione meta- del libro non riguarda solo la natura potenzialmente introflessa, appunto, del linguaggio. Questo gusto attraversa senza dubbio l’intero libro, e aggancia i vari racconti (ad esempio in Resoconto sperimentale si parla di «aprosdoketon» e Aprosdoketon è anche il titolo del racconto che viene subito dopo, nonché quello di un paragrafo di Lettera all’usurpatore, il testo ancora successivo) o addirittura tra testo e paratesto (la dedica «Niente per niente» la ritroviamo anch’essa nella Lettera all’usurpatore, come messaggio della «tavola»).

Il punto, però, è vedere il legame forte tra questa ritorsione strutturale e stilistica, l’immaginario del libro (dominato appunto dal laboratorio, ma anche da altre forme di violenza, come quella verbale e caotica di Invocazione) e infine della carica, come dire, performativa del libro. A questo proposito è interessante pescare un altro passaggio da Una possibilità del linguaggio: «la letteratura che implica se stessa […] nei suoi meccanismi interni, non produce innocui esercizi di stile: essa al contrario mette in gioco i modi di appropriazione e i processi di attribuzione e significazione; essa segretamente chiede: “di chi è il senso?” –, si tratta, alla lettera, di una prospettiva politica». Per Zucchi, insomma, la metaletteratura mette in discussione non tanto la capacità referenziale del testo, in termini semiotico-ontologici, bensì, soprattutto, la sua parzialità politica, la sua natura storicamente situata e, quindi, ideologicamente orientata – così come avviene nel laboratorio, dove il processo scientifico non prescinde, e anzi è condizionato, da chi detiene il progetto, predispone e controlla l’esperimento.
Narratore e usurpatore
Di questa che potremmo chiamare pragmaticità metaletteraria, sono poli fondamentali, nel libro, il «narratore» e l’«usurpatore». Anche qui, la scrittura di Zucchi non permette di identificare questi ruoli in maniera manichea e definitiva. Non è possibile infatti rintracciare una drammaturgia stabile, nei racconti, neanche nel più esteso Resoconto sperimentale: non solo tutti i testi sono divisi in paragrafi diseguali che spostano continuamente il focus, ma soprattutto se il linguaggio non è neutrale, e vuole essere preso per la gola proprio in questa sua parzialità, ogni forma di rispondenza biunivoca costruita al suo interno non può che essere, paradossalmente, inaffidabile.

Narratore e usurpatore, perciò, vanno presi come funzioni (e Autobiografia della funzione è proprio il titolo del racconto incipitario), come ruoli di massima in cui i personaggi (e anche gli attori extra-letterari, l’autore e il lettore) transitano, ne occupano momentaneamente lo spazio e perciò, anche involontariamente, ne ripetono la dinamica. Ma tale liquidità non è solo l’effetto di una scrittura costruita dentro un linguaggio già compromesso, è anche la condizione di possibilità del libro. Il narratore incarna il potere, è minacciato («il NARRATORE mente: non sa ANCORA che NOI lo uccideremo»), ma è anche l’artefice del linguaggio del libro – volendo, è lo scienziato (il potere) del laboratorio. «L’intenzione è vaga, la missione è pratica»: si trova qui, nell’esergo dell’ultima pagina, la guida più sintetica a comprendere qual è la sfida (di scrittura e politica) del “demolition job”: uccidere il narratore in quanto espressione di potere (come nel finale di Aprosdoketon), ma farlo, paradossalmente, all’interno delle coordinate poste da lui stesso. All’interno del suo laboratorio.
Antonio Francesco Perozzi
[1] Mi permetto di rimandare a un mio pezzo precedente, appunto su La memoria dell’uguale: https://culturificio.org/la-memoria-delluguale-di-alfredo-zucchi/
[2] Per Una possibilità di linguaggio. Pierre Menard come metodo, invece, si veda qui: https://www.rivistagradozero.com/2022/01/28/discendere-distruggere-su-una-possibilita-del-linguaggio-di-alfredo-zucchi/

