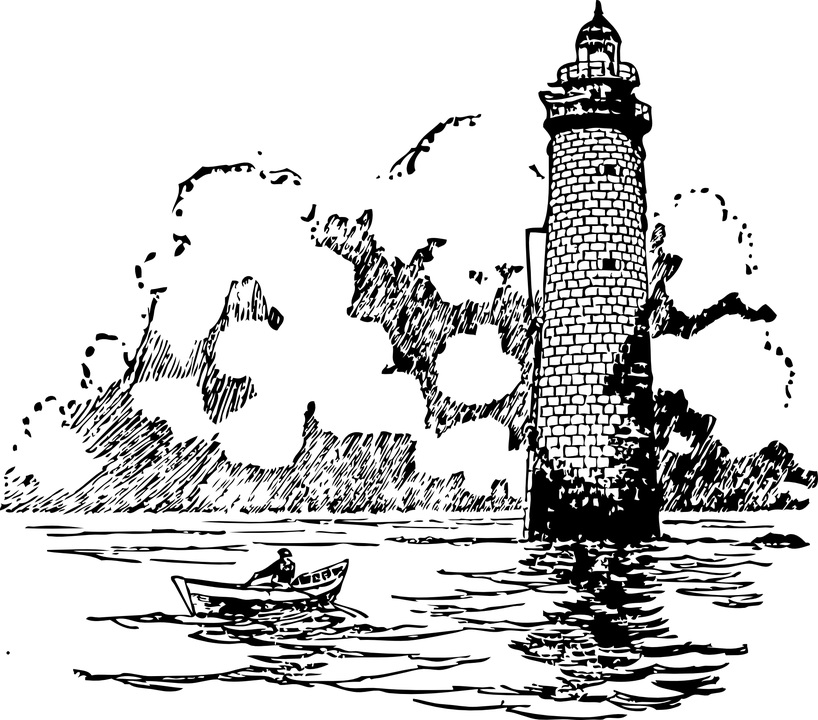
Racconto: La sirena del faro – Davide Ricchiuti
I
Quella sera ero salito sulle scale a chiocciola del faro di Bloom con la mia Ibanez Artwood a tracolla, dopo aver servito gli ultimi clienti al ristorante. Sono passato attraverso la botola e mi sono inerpicato sul terrazzino esterno per respirare un po’ di oceano.
Cercavo Adele all’orizzonte del visibile, come tante altre volte da quando mi ero trasferito su quest’isola.
A essere sincero, avevo immaginato tutt’altro, scappando da casa, due anni fa. Volevo sottrarmi a quella concatenazione scontata di eventi tipo studia, lavora, crepa nello stesso posto in cui sei nato. Io avevo fatto un solo, vero, viaggio nella mia vita, d’accordo. Ma in quel viaggio avevo incontrato Adele. È stato subito dopo la laurea, ero partito da solo e avevo voglia di andare il più lontano possibile da casa. Quando ci siamo conosciuti lei faceva la cameriera al faro dell’isola per mantenersi durante l’ultimo anno alla facoltà di Storia.
Adesso dovevo indossare le cuffie, impugnare la chitarra e chiudere gli occhi sul punto più alto del faro per ricordare l’odore della sua pelle sulla mia. Era lì che andavamo di notte, dopo il lavoro. Ascoltavamo musica e lei cantava. Portavamo una bottiglia di vino e facevamo l’amore fino a che il vento non ci congelava. Avevamo le chiavi del faro e sapevamo come disconnettere il sistema di allarme, il proprietario lo aveva spiegato a Adele, tempo prima. All’inizio lei era stata assunta per pulire il ristorante a fine serata più i tre piani superiori, dove ogni tanto si tenevano mostre e piccoli concerti.
Quella sera ho premuto play su Spotify e ho iniziato a suonare con la chitarra gli accordi delle canzoni che stavo ascoltando in cuffia. Il suono della schiuma che nasceva dalle onde infrante sugli scogli s’intrometteva nelle fessure scoperte tra la mia pelle e le cuffie. Le tenevo sempre leggermente scostate dalle orecchie per sincronizzare i movimenti delle mani sulla mia Ibanez con i pezzi che uscivano dal telefono. Ma quella notte ero talmente immerso nel fluire dei suoni che non capivo più se quelle canzoni le avevo scritte io o l’autore che compariva sullo schermo del cellulare.
Lo stridio di un gabbiano di passaggio mi ha fatto aprire gli occhi all’improvviso. The Fear, l’ultima canzone della playlist di Ben Howard, era appena finita. Sentivo ondeggiare il riverbero di una corda di chitarra da destra a sinistra e poi disperdersi in un luogo imprecisato intorno a me. Sembrava che fosse stata graffiata dal velluto invece che da un plettro, quella corda. Per quanto era profondo e intenso il suono, immaginavo che si trattasse del Mi, la prima corda dall’alto nel manico della chitarra. Quella che mi aveva provocato più escoriazioni sulle dita, prima che si formassero i calli. Adele diceva sempre che le sarebbe piaciuto essere una rockstar. Diceva che io ero bravo a suonare la chitarra distorta e che lei avrebbe cantato. Diceva che sarebbe stata più rock di Janis Joplin, più sexy di PJ Harvey, più incazzata di Pink.
Solo un mese prima di trasferirsi a San Francisco con Damien, il Business Strategist di Google in vacanza a Bloom che ci aveva provato con lei per un’intera settimana al ristorante del faro, Adele diceva «Ce la faremo, scriviamo annunci su internet, mettiamo su il nostro gruppo, la nostra vita cambierà». E io scherzavo, le rispondevo: «Certo, come no? E se non ce la facciamo comunque tu sarai sempre la migliore cantante del mondo, per me».
Adele diceva: «Puoi giurarci che ce la facciamo. Non vedi che tu sei arrivato su quest’isola?».
E io rispondevo: «Che c’entra?».
E lei: «C’entra. Hai presente le sirene che cercano di attrarre Ulisse con il loro canto sull’isola?».
«Veramente no, ho solo un vago ricordo di questa storia».
«Vabbè, è semplice, lui si fa legare all’albero della sua nave che passa vicino all’isola delle sirene per non cadere in tentazione ascoltandole cantare».
«Ok».
«Ecco, loro non ce la fanno a farlo scendere dalla nave. Ma tu sei qui, no? Con te ha funzionato».
«In effetti», ho detto sorridendo, «forse tu sei la sirena di Bloom».
E lei ha risposto: «Certo, io sono la sirena del faro».
II
Quando Adele mi ha confessato che sarebbe partita per gli Stati Uniti, io stavo iniziando il turno serale al ristorante. L’ho incrociata sul retro della cucina. Lei si stava togliendo l’uniforme e mi ha detto solo «Mi dispiace, forse non ci credevamo abbastanza». Quattro giorni dopo mi ha scritto su Whatsapp: «Non so perché ti ho lasciato all’improvviso, ma mi sentivo così strana e bloccata nella nostra vita e non riuscivo a parlarne. Ero delusa. C’era qualcosa in te che mi allontanava dai miei obiettivi, non so. Se vogliamo realizzare qualcosa insieme non posso crederci solo io. Quando Damien ha detto la parola San Francisco è stato come se un terremoto di non so quale magnitudo avesse iniziato a circolarmi nel sangue all’improvviso, capito?». E dopo qualche minuto Adele ha scritto ancora «Spero capirai. Non volevo ferirti». E in un altro messaggio, proprio appena dopo che avevo visualizzato i precedenti, ha aggiunto «Ti voglio bene». Io non avevo risposto. È passato quasi un anno ormai, ma stanotte ho avuto l’impulso di scriverle «Sei perfetta. Sei vitale, sei stronza, sei vera. È così che avrei sempre voluto essere anch’io. Farei di tutto per riaverti con me. Anche l’impossibile», e l’ho scritto davvero. Solo che non ho inviato il messaggio. È rimasto lì, sullo schermo, con la barra blu di whatsapp a lampeggiare alla fine dell’ultima parola. Non riuscivo a decidermi a premere il tasto d’invio.
Pensavo a questo quando, a un certo punto, qualcosa sul terrazzino del faro dove mi trovavo è andato fuori controllo. Scomparsa l’eco della chitarra di The Fear, avevo riaperto gli occhi e, tentando di mettere a fuoco lo schermo del cellulare, mi sono accorto che mi girava la testa. Per un istante credo che il mio corpo abbia ruotato su se stesso senza che io riuscissi a controllarlo. I miei occhi adesso puntavano la luce del faro. All’improvviso mi si è offuscata la vista e c’è stata un’intermittenza della lampada più lunga del solito. Sono stato avvolto in un vortice di vento che sferzava dall’oceano verso la terraferma. E in quel frangente di buio prolungato devo essere inciampato nello sportello della botola che non si era chiuso bene oppure c’era dell’olio da manutenzione per terra, non so. So solo che sono caduto dentro la lanterna intralciando la rotazione dei cristalli del faro. Il vetro della lampada si è frantumato e per una frazione di secondo il dolore è stato insopportabile. Il telefono è caduto sul pavimento del terrazzo, lontano dalla mia presa, col messaggio non ancora inviato. La chitarra ha rimbalzato sulla ringhiera ed è stata travolta dal vento producendo una strana melodia, fino a che non ho sentito più nulla.
Ma l’ultimo ricordo che ho prima di scivolare al centro dell’incandescenza non è il suono della chitarra. No.
III
Ho cominciato a disgregarmi poco a poco, mentre parti del mio corpo già brillavano nel bulbo di vetro del faro e io, in mezzo al dolore, pensavo che avrei dovuto inviare quel messaggio. Pensavo che ero sempre stato in ritardo su tutto, sulla mia vita con Adele, sui nostri sogni e adesso anche su quel cazzo di messaggio di whatsapp.
Un istante prima di perdere conoscenza, però, ho capito che forse, stavolta, non tutto era perduto. Adesso che stavo diventando alogeno e che mi sarei prodotto per contatto tra il filo di andata e il filo di ritorno del tungsteno nella lampada del faro, cominciavo a pensare che avrei davvero riconquistato Adele. Sapevo che adesso lei mi avrebbe visto a qualsiasi distanza, ne ero certo. Perché ora sì che avevo tentato di tutto. Anche l’impossibile.
Prima di diventare luce ho sentito un suono. Ecco, quello è il mio ultimo ricordo. Il suono della sirena del faro.
Davide Ricchiuti

