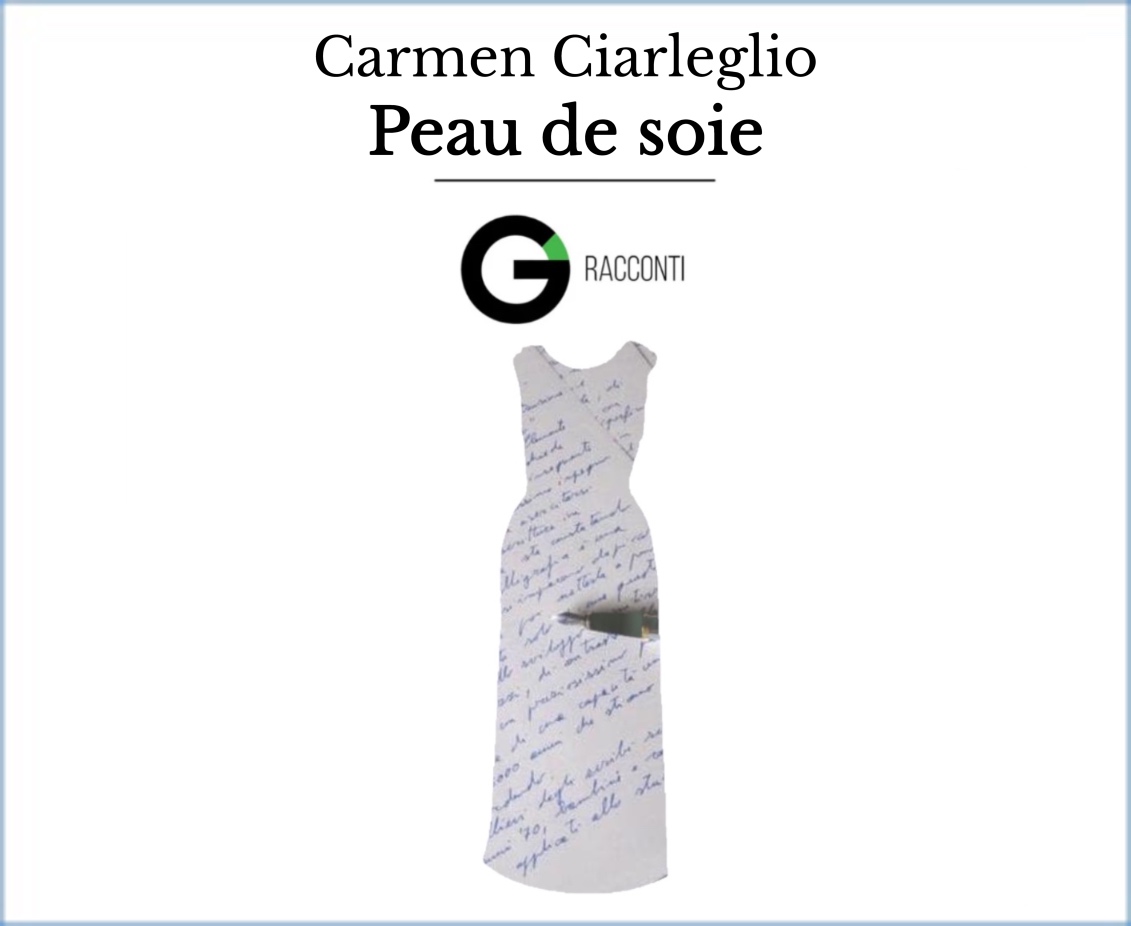
Racconto: Peau de soie – Carmen Ciarleglio
Che lavoraccio provare a spegnere le stelle, svitare il sole, scollare uno spicchio di luna. Che brutta infamia volgere lo sguardo a questo volto ostinato, con gli occhi in volo verso un bersaglio che come dardi puntano al centro pieno.
Immagino se tutti avessimo sempre a portata di mano un pettine. Quanta placida manifestazione di sé in ogni porzione di terra, dico tra me.
Io pettino i capelli solo sotto la doccia, dopo la passata di balsamo. Da anni è così, da quando non modifico la mia chioma se non sull’orlo. Almeno quello. Così dicono bisogna fare per farli crescere in ogni caso sani e forti. Allora segno su un post-it: Ognuno si sente esperto, ognuno rende arti inutili frammenti del proprio fare. Lo scrivo per ricordarlo perché le informazioni che ingurgiterò a breve scorrendo feed, leggendo mail, rispondendo alle chiamate dei clienti, non sono pro-memoria. Incitano al gioco perverso dell’a-tutti-i-costi-nonostante-le-emozioni.
Mentre scrivo una piega della maglia che indosso si sgonfia sul tavolo laccato nero. Mi accorgo in quel momento essere la stessa maglia che indossavo la mattina che trovai mio padre esanime sul pianerottolo di casa. Esanime è una di quelle parole che alle 9.00 di una mattina di quasi tre anni fa vestì di peau de soie il proprio significato. Tutto divenne di seta, scintillante anche il riverbero del defibrillatore.
La seta è fatta di fibroina, proteina prodotta anche dalle larve.
La larva è ciò che un insetto è prima della metamorfosi.
Mio padre morto era di seta. Mio padre è diventato larva.
Ci penso vestendomi, con il capo un po’ pendente, quasi stupita delle mie corrispondenze da ricordanza. Infilo uno dei miei vestiti preferiti, a pois. Scarpe comode e via. Mi alzo dalla sedia ed è già domani.
Alle 5.30 vivo il mio momento di disconnessione e cammino, corro, mi fermo. Saluto la signora Maria che mantiene intatto quel modo di avanzare deciso e impettito di chi conosce meglio l’odore della sorte. Percorro la via interna della pista ciclopedonale, quella che costeggia in basso la collina, e rifletto sul fatto che se in uno dei campi lasciati all’imprevedibilità che incontro lungo il tragitto confinassimo tutti i nostri pensieri avulsi dal prossimo, potremmo divenire i prossimi di noi stessi così la vergogna salirebbe a galla e noi andremmo giù.
Continuo a pensarci mentre risalgo le scale di casa, poi mentre preparo il caffè, e ancora mentre spalanco le finestre. La lancetta segna quasi le 7.00, la stessa ora di sempre in cui mi dico che non voglio più giudicare, anche se lo faccio.
Da diciotto anni soffro di paralisi del sonno. Quando lo racconto molti ridono, ma grazie a questa sgarberia ho capito che l’ignoto è un pagliaccio con un coltello in mano.
Giudicare a tutti i costi è un’amabile costante e una irrefrenabile idiozia.
Poi arriva il momento della doccia, del conteggio delle gocce d’acqua che fanno tappa sul mio ventre, della convinzione che dall’alto i piedi sono più belli. E immagino le mani al loro posto e i piedi al posto delle mani.
La mente quando fantastica è meravigliosa. Se io potessi vivere di fantasticherie, al posto delle orecchie ci sarebbero fiori, degli occhi nidi per uccelli, del cuore lucciole. Corro a disegnare questa mia immaginifica potenzialità.
Ennesima chiamata di presunto spam in arrivo. Non rispondo. Sono seduta dietro al tavolo laccato nero, con la stessa maglia, rosa, consumata. Avverto ancora le maniche fradice di sudore di quel 21 luglio, non per il caldo, ma per un saluto mai scambiato.
Mia madre attraverso un messaggio mi dice che zia Anna ci ha invitate a casa sua per pranzare insieme la domenica. Si può fare, rispondo.
Scopro il vaso dei tempi che furono.
Noi cinque intorno al tavolo in marmo della cucina con al centro due candele a illuminare la cena. Le battute dei miei genitori per far sembrare tutto un gioco. Lo sconforto dei miei genitori per nascondere il reale con il sembrare.
Segno su un post-it: Non avere abbastanza soldi, abbastanza pazienza, abbastanza comprensione per stare dietro a tutto non è una vergogna.
Nevvero?, chiedo a mia madre.
A volte penso che il suo approcciarsi al mondo sia lodevole. Penso che glielo dirò. Non oggi.
Riprendo la mia corsa per cercare di stare dietro al primo stiracchiarsi del sole e per sfuggire ai primi sbadigli della luna. E ancora poi le scale, l’ingresso in casa, la doccia e il pettine per i miei capelli di peau de soie.
Carmen Ciarleglio, caudina, 1989. È copywriter, narratrice e poeta. Ha all’attivo un progetto digitale dal titolo Le avventure di Pernacchio. È autrice della raccolta di poesie Poesimentario (Controluna Edizioni).

