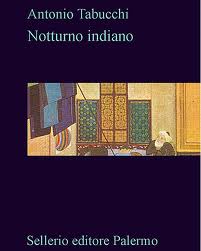
Notturno indiano: viaggio in un’India occidentale
Notturno indiano è un romanzo di Antonio Tabucchi edito nel 1984 presso la casa editrice Sellerio.
Il libro descrive il viaggio di un uomo che, supportato da una piccola guida turistica, si aggira per il territorio indiano alla ricerca di un amico perduto, Xavier.
Intenzionato a recuperare tutte le informazioni che le persone sanno fornirgli sull’amico, il protagonista incontra svariati e singolari personaggi con i quali si intrattiene, venendo a contatto con spaccati della cultura indiana.

Il percorso del personaggio è frazionato in varie tappe, ognuna delle quali si contraddistingue per una specifica avventura o per un incontro particolare, il cui svolgimento si esaurisce nell’arco di un capitolo; incontri che peraltro vengono ad assorbire e annacquare quasi completamente la vicenda personale del protagonista, dando così l’impressione di essere loro il vero intento e spunto narrativo.
Gli scenari che ci vengono proposti si presentano come plurimi e tra loro incongrui, come lo stesso autore dichiara esplicitamente nella nota iniziale: la ricerca stessa di Xavier perde consistenza verso la fine del libro e da fantomatico motore del viaggio, lascia emergere alcuni dubbi sulla sua reale natura di effettivo scopo, scivolando più verso il confine del pretesto, anche se, eretto al posto di cosa, non è ben dato saperlo.
Si tratta, tutto sommato, di un viaggio attraverso l’India, anche se della vera e intima natura dell’India sembra restituire solo piccole impressioni, scorci minimali che, seppur intensi, si esauriscono in una ristretta descrizione: del malfamato “Quartiere delle Gabbie” (prima meta del protagonista) ci viene detto:
“(…) era molto peggio di come me lo ero immaginato. Lo conoscevo attraverso certe fotografie di un fotografo celebre e pensavo di essere preparato alla miseria umana, ma le fotografie chiudono il visibile in un rettangolo. Il visibile senza cornice è sempre un’altra cosa. E poi quel visibile aveva un odore troppo forte. Anzi, molti odori.”
cui segue una minuta descrizione dell’ambiente dell’ampiezza di circa mezza pagina.

Alla visita presso l’ospedale di Bombay viene offerto maggior respiro descrittivo rispetto al caso precedente, ma risulta comunque riduttivo se confrontato con lo spazio dedicato all’altra faccia del territorio indiano: l’India turistica dei grandi hotel di lusso, sfarzosa fino all’eccesso.
Il fascino e il potenziale indiano, sia esso mistico – come nell’episodio dell’incontro con l’Arhant (un profeta jaino) -, religioso – nell’incontro con un jainista – o culturale – nel colloquio avvenuto tra il protagonista e un intellettuale della Theosophical Society – restano mozzi e sfumati, lasciando sempre vivo il sentore di qualcosa di inespresso o addirittura inarrivabile.
Un esempio è fornito dall’episodio del piccolo e mostruoso Arhant: il profeta, una volta interrogato, asserisce di non poter leggere il karma del protagonista, individuando nell’uomo solo maya (l’apparenza del mondo) e niente atma (l’anima individuale), lasciando quindi in sospeso lo smanioso desiderio di sapere e investigare su noi.
Lo stesso avviene nell’incontro con il jainista in cui due religioni distinte, e oserei dire due atteggiamenti mentali differenti, colloquiano tra loro: l’incapacità di riconoscere una preghiera jainista, scambiata per l’ululio di uno sciacallo, si risolve nella seguente confessione:
“Per me era impossibile decifrarlo. L’India era anche questo: un universo di suoni piatti, indifferenziati, indistinguibili.”
La conversazione tra i due personaggi si configura come un colloquio, come uno scambio di per sé possibile – come effettivamente avviene -, ma che pare sempre a un passo dal varcare il confine dell’incomunicabilità, lasciando intendere come, quella messa in discussione, sia solo una sottile porzione, un’anfrattuosità costiera di ambedue le personalità, il cui avvistamento è sempre e soltanto possibile da un isolotto distinto e conseguentemente distante e limitato. Lo scarto tra i due, lo si può evincere dal non detto, dall’alluso – sia esso voluto o meno -: un entroterra irraggiungibile di cui è data solo la possibilità di una presa di coscienza; in definitiva, un’alterità.
I misteri, così come le usanze indiane, restano in conclusione elusi; tutt’al più accolti in superficie, sfiorati e “accarezzati” con estrema e, auspico, consapevole fuggevolezza.
Lo stesso personaggio di Christine, che compare verso la fine del libro, si presta a portavoce di questa politica dell’elusività, del cui uso, peraltro, l’autore non lascia sufficienti tracce giustificatorie, recludendo quindi tutte le possibili spiegazioni nell’alveo di semplici ipotesi soggettive.
“Lei è mai stato a Calcutta?”.
Scossi la testa. “Non ci vada” disse Christine, “non faccia mai questo errore”.
“Pensavo che una persona come lei pensasse che nella vita bisogna vedere il più possibile”.
“No”, disse lei convinta, “bisogna vedere il meno possibile”.
Quella descritta è un’India occidentale, vista con l’occhio di un occidentale il quale, tra i vari pernottamenti in hotel di lusso, si compiace, durante i suoi spostamenti, di osservare gli scenari che gli sono di volta in volta proposti e che si susseguono nei vari capitoli del libro, originandosi in maniera del tutto casuale, non fosse altro che per quell’esile e striminzito filo rosso di nome Xavier, evocato e mai presente.
Per concludere mi azzardo a fornire una mia interpretazione del titolo: notturno è lo sguardo del protagonista che osserva l’India nella penombra, semioscurità forzata e dettata anche da un punto di vista imprescindibilmente occidentale. Per quanto riguarda invece il riferimento alla matrice indiana, non vi era altra possibilità di nominarla che tramite un aggettivo, subordinato e legato a un sostantivo che sottintende una percezione altra, occidentale, e che relega l’India a sfondo di una vicenda personale poco nitida.
Claudia Corbetta

